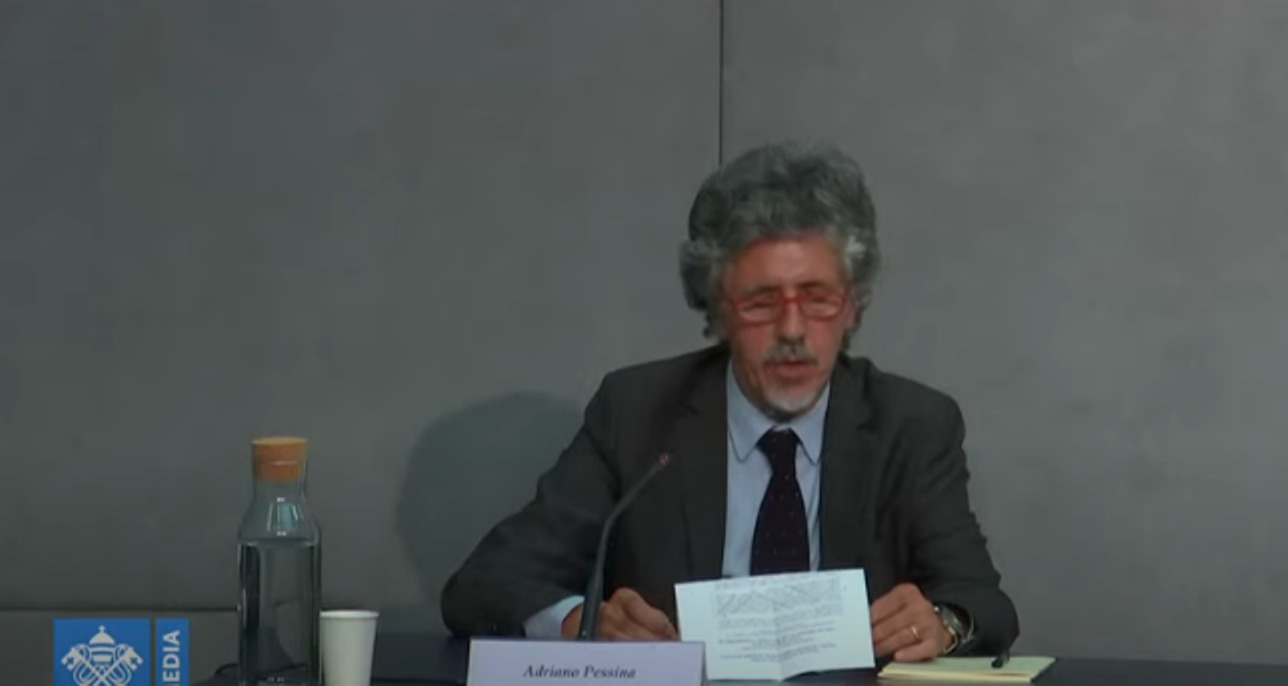Alle ore 11.30 di questa mattina, presso l’Aula “Giovanni Paolo II” della Sala Stampa della Santa Sede, ha luogo una Conferenza Stampa di presentazione della Lettera Samaritanus bonus sulla cura delle persone nelle fasi critiche e terminali della vita, redatta dalla Congregazione per la Dottrina della Fede. Intervengono: l’Em.mo Card. Luis Francisco Ladaria Ferrer, S.I., Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede; S.E. Mons. Giacomo Morandi, Segretario della medesima Congregazione; la Prof.ssa Gabriella Gambino, Sotto-Segretario del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita; il Prof. Adriano Pessina, Membro del Direttivo della Pontificia Accademia per la Vita. Ne riportiamo di seguito l‘intervento del Prof. Adriano Pessina:
Intervento del Prof. Adriano Pessina
Le problematiche sollevate dalla Lettera “Samaritanus bonus” in rapporto alle istanze odierne dell’antropologia.
In un periodo storico, in cui sembra più facile confidare nella scienza e nella tecnica che negli uomini, la Lettera Samaritanus Bonus pone al centro, con chiarezza, l’importanza delle relazioni umane nelle situazioni critiche della malattia e nelle fasi terminali della vita. La nostra è un’epoca che evoca la dignità personale, l’autonomia, la libertà individuale, ma poi delega alla tecnologia, alle scienze mediche e farmacologiche le tecniche di cura e di assistenza medica; e quando la tecnologia non può più nulla, quando le fasi della malattia richiedono la pazienza del coinvolgimento personale e la morte si fa prossima, ecco emergere la tentazione di delegare alla morte – nella forma del suicidio assistito, dell’eutanasia, dell’abbandono terapeutico – quella risposta alla domanda di “senso” della vita cui nessuna macchina, neppure la più sofisticata intelligenza artificiale, può rispondere.
Questa Lettera è, nella sua sostanza, un invito a ridare “senso” ai tempi lunghi della malattia e della disabilità, a ridare, cioè, “senso” alla condizione mortale dell’uomo, senza abbracciare nessun vitalismo, e al contempo, senza mai banalizzare la serietà del morire: soprattutto in questo contesto storico in cui proprio il processo del morire – tra eccessi tecnologici e ideologici – è continuamente esposto a modelli culturali erosivi che ignorano il nesso che lega, indissolubilmente, il riconoscimento del valore dell’essere umano con il divieto di uccidere. Il liberismo contemporaneo, con l’alibi del rispetto dell’autonomia del singolo cittadino, dell’osservanza della sua libertà, ha fin qui varato alcune leggi che, nelle loro conseguenze pratiche, hanno trasformato il giudizio individuale di alcuni sulla loro vita in una serie di criteri generali che di fatto pesano come un implicito e ingiusto giudizio su tutti coloro che versano in analoghe condizioni cliniche: si è passati così dall’individuale all’universale, dall’eccezione alla regola e si è minato quel principio etico e politico del “non uccidere” che è la base di ogni rapporto democratico tra pari.
Quegli assetti legislativi che, in alcuni Paesi, permettono, oramai, il suicidio assistito e l’eutanasia, stanno, purtroppo, favorendo un milieu culturale in cui le persone che si trovano in gravose e perduranti condizioni di malattia, o devono affrontare le fasi terminali della vita, rischiano di essere ingiustamente stigmatizzate come indegne di vivere, rappresentate come coloro che danneggiano le autonomie altrui perché – pur segnate dalla malattia – non vogliono cedere alla disperazione e anticipare la loro morte, assecondando quella logica dello “scarto” di cui, peraltro, ha parlato ripetutamente Papa Francesco in questi anni di pontificato. Da qui l’innesco di una logica produttiva che colpisce indistintamente tutti coloro che, a fronte delle loro condizioni di salute, non rientrano in quel nuovo parametro che è la cosiddetta “qualità” della vita che, da modello a cui tendere, è diventato criterio di discriminazione antropologica. Un criterio e una mensura, quello della “qualità della vita”, che, in realtà, descrive solo una “quantità” di funzioni – appunto misurate facendo riferimento al pieno possesso delle capacità fisiche e psichiche – che finisce con il condannare chi se ne trova privato, per malattia o disabilità gravissima. Un modello culturale che, a lungo andare, incide anche nell’autorappresentazione del singolo individuo, facendolo sentire un “peso”, economico, esistenziale, affettivo per la società e persino per i suoi famigliari.
Con il risultato che in simili società prestazionali e pelagiane, l’io personale, disarticolato in funzioni, finisce con il risentire sempre dello sguardo grave di un io sociale antisolidaristico e prestazionale, rischiando di diventarne definitivamente vittima, quando fragile e ammalato. Ma l’essere umano malato non è ‘cascame’, non è misurabile in base alle sue funzioni. E questa Lettera, dunque, ci ricorda che non ci sono vite indegne di essere vissute e che se non c’è nulla di amabile nella malattia, nella sofferenza e nella morte, che vanno per questo affrontate e combattute, è altrettanto vero che è proprio l’uomo, malgrado le sue limitazioni, fragilità, fatiche, che è sempre degno di essere amato. Occorre, perciò, tornare a “vedere” e custodire il valore dell’essere umano nella sua concretezza esistenziale, unica e irripetibile.
Il Buon Samaritano è, allora, una figura teologica e antropologica capace di ripristinare uno sguardo umano. È lo sguardo consapevole di chi non confonde il concetto di inguaribile con il concetto di incurabile. Lo sguardo di chi non usa del criterio della “qualità” per abbandonare la persona alla sua disperazione sapendo riconoscere, invece, una qualità intrinseca all’uomo stesso: quella “qualità” che in termini laici si chiama dignità della vita umana e in termini cristiani sacralità della vita umana. Viviamo in un’epoca di profonde solitudini, dissimulate: l’istanza dell’autonomia, pur nella sua importanza, ha finito con il trasformarsi nella logica dell’abbandono, terapeutico e assistenziale, perché nessuna autonomia è in sé in grado di reggere il peso del dolore e della sofferenza propria e altrui se non sa riconoscere i valori della reciproca dipendenza e solidarietà. In questa prospettiva valoriale, la Lettera Samaritanus Bonus, che non è un semplice trattato o un protocollo, si presenta come un invito preciso all’uomo contemporaneo: l’esortazione a stare accanto alle persone, a farsi prossimi nelle ore della Croce.
Questa Lettera ci ricorda che il Dio che resta fedele all’uomo, rappresentato dal Buon Samaritano, e lo salva, è lo stesso Dio che ha vissuto l’esperienza della sofferenza, dell’abbandono, dell’incomprensione, della morte: Egli sa di che cosa si tratta, non è un semplice “osservatore” della condizione umana. Ma, inchiodato su un legno di condanna e di tortura – che sembra evocare quell’uso sproporzionato della tecnologia che inchioda i pazienti; deriso da chi non lo capisce; abbandonato da chi non ha avuto il coraggio di partecipare alle sue sofferenze – Egli conserva la sua fiducia nella fedeltà del Padre e nell’amore straziante della madre che sta sotto la croce con i discepoli fedeli. Stabat Mater: quando non si può fare nulla si può, però, stare accanto a chi soffre. Una scena corale, quello della Croce, in cui si riassumono i conflitti teorici e esistenziali che circondano le fasi terminali della vita. Ebbene, penso che in questa società secolarizzata in cui molte persone muoiono da sole e desiderano e chiedono la morte come rimedio al peso della vita, si possano trovare elementi di riflessioni sull’importanza di stare accanto ai morenti e ai sofferenti. Non dimentichiamo, a ogni modo, che la solitudine del malato è anche spesso la solitudine di chi si prende cura di lui.
E questa Lettera, inoltre, introduce il concetto di comunità sanante, una bella intuizione che dà voce a tutta la centralità delle relazioni messe in evidenza dall’antropologia contemporanea, eppure non sufficientemente praticata all’interno degli attuali processi di cura e di assistenza. Una comunità sanante dovrebbe esprimere, perciò, la duplice dimensione del prendersi cura sia del malato sia di chi lo accudisce. Un circolo virtuoso, che va al di là della logica dei protocolli e delle procedure, per quanto utili siano, perché la speranza si palesa prima di tutto in una compagnia capace di ascolto e condivisione. Le cronache di questi ultimi mesi, del resto, hanno messo in luce come la figura del buon samaritano sia un’urgenza e un’emergenza sociale. In piena pandemia – in questa sorta di nostro doloroso cammino da Gerusalemme a Gerico – i malati di Covid19 hanno trovato nei medici, negli infermieri, negli operatori sanitari, il buon samaritano che ha saputo stare accanto a loro: uno stabat che testimonia che quando non c’è nulla da fare c’è, anzi, molto da fare. Se il COVID 19 ci ha ricordato la nostra fragilità, il corpo contagiato, in tutta la sua materialità, ci ha pure obbligato a riconfigurare i legami e a ‘vegliare’ sull’altro, senza fraintendimenti. Ma soprattutto a fare come Dio: ad avere “compassione”, cum patior, quando – passando accanto a qualcuno – questi è battuto e ferito. Poiché nessuno nella sua sofferenza ci è mai estraneo.